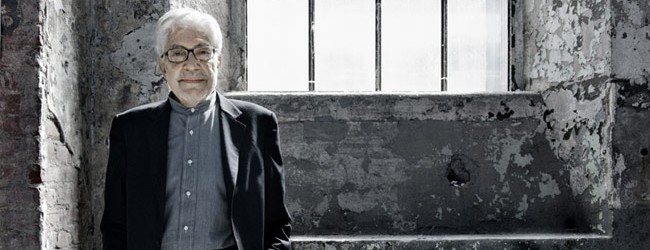
SPECIALE AUTORI VENEZIA 70
Se permettete parliamo di Scola
A lungo tacciato di “bozzettismo” dalla critica nostrana, Ettore Scola ha impiegato anni per raggiungere la dovuta consacrazione a figura centrale del cinema italiano la cui carriera, pur con alti e bassi, si è fatta più di altre emblema dei mutamenti storici e culturali del Paese e per riflesso della cultura nazionale.
Nato nel 1931, Scola diventa sceneggiatore cinematografico dopo una gavetta in redazioni editoriali e in radio; sono soprattutto le collaborazioni con Pietrangeli e Risi che gli permettono di trovare un proprio stile, felice sintesi dell’attenzione al quotidiano del primo e della feroce comicità quale strumento critico del secondo, che caratterizza Se permettete parliamo di donne, La congiuntura e Il vittimista. Con L’arcidiavolo il regista introduce una tematica a lui cara – ripresa poi nei più tardi Passione d’amore, Il mondo nuovo, Ballando, ballando, Il viaggio di Capitan Fracassa e Concorrenza sleale, sviluppo ideale di ’43-’97 – ovvero l’essenza metastorica dell’uomo, identico a se stesso pur nel variare dei tempi, facendo così del passato l’antecedente del presente, diverso ma uguale a ciò che è stato. Alla fine degli anni Sessanta, con l’affievolirsi della satira di costume, Scola fa i conti con la borghesia, oggetto di una commedia ormai incapace di cogliere i delicati cambiamenti sociali in atto. Attraverso i personaggi di Riusciranno i nostri eroi a ritrovare l’amico misteriosamente scomparso in Africa? e la loro sintomatica fuga dalla realtà e dalle contraddizioni del consumismo, e Il commissario Pepe che paga di tasca sua lo scoprire gli interessi del Potere a cui è posto a tutela, si arriva alla condanna definitiva dell’italiano furbo e arruffone ne La più bella serata della mia vita, modello poi saltuariamente recuperato più per gioco che altro ad esempio negli episodi di Signori e signore, buonanotte. Da qui il cinema dell’autore di Trevico subisce un cambio di registro. Dramma della gelosia, tutti i particolari in cronaca, Permettete? Rocco Papaleo, Trevico-Torino e Brutti, sporchi e cattivi si aprono con tono giustificatorio all’universo dei poveri ed emarginati, mentre C’eravamo tanto amati avvia un’indagine a ritroso nella dimensione “universale” della borghesia sullo sfondo degli avvenimenti che hanno segnato l’Italia. Le piccole storie singolari diventano racconti comuni, come in Una giornata particolare, La terrazza, La famiglia e La cena. La Storia diventa diuturno, muta nelle apparenze, ma non nella sostanza e lascia i suoi segni sugli eventi di ogni giorno. La malinconia dei crepuscolari Maccheroni, Splendor, Che ora è cede il posto al turbamento per la crisi politica e valoriale degli anni Novanta. Scola guarda indietro con nostalgia (Mario, Maria e Mario) e con sgomento all’oggi (Romanzo di un giovane povero): al pari di Un borghese piccolo piccolo, non c’è più spazio per la risata, I nuovi mostri prima derisi ora non consentono indulgenza alcuna. Dopo i documentari della Fondazione Cinema nel Presente, con Gente di Roma l’autore torna alle amate microstorie in un attento e appassionato ritratto del melting pot della capitale; e adesso, aspettando Che strano chiamarsi Federico, fuori concorso a Venezia 2013 e in sala dal 12 settembre, personale profilo – come già Sergio Amidei: ritratto di uno scrittore di cinema – dell’amico Fellini, non resta che sperare Scola torni presto a raccontare l’odierno, sgraziato certo, ma ricco di quei tratti umani che il regista ha sempre saputo (e aiutato a) osservare e capire.
a lui cara – ripresa poi nei più tardi Passione d’amore, Il mondo nuovo, Ballando, ballando, Il viaggio di Capitan Fracassa e Concorrenza sleale, sviluppo ideale di ’43-’97 – ovvero l’essenza metastorica dell’uomo, identico a se stesso pur nel variare dei tempi, facendo così del passato l’antecedente del presente, diverso ma uguale a ciò che è stato. Alla fine degli anni Sessanta, con l’affievolirsi della satira di costume, Scola fa i conti con la borghesia, oggetto di una commedia ormai incapace di cogliere i delicati cambiamenti sociali in atto. Attraverso i personaggi di Riusciranno i nostri eroi a ritrovare l’amico misteriosamente scomparso in Africa? e la loro sintomatica fuga dalla realtà e dalle contraddizioni del consumismo, e Il commissario Pepe che paga di tasca sua lo scoprire gli interessi del Potere a cui è posto a tutela, si arriva alla condanna definitiva dell’italiano furbo e arruffone ne La più bella serata della mia vita, modello poi saltuariamente recuperato più per gioco che altro ad esempio negli episodi di Signori e signore, buonanotte. Da qui il cinema dell’autore di Trevico subisce un cambio di registro. Dramma della gelosia, tutti i particolari in cronaca, Permettete? Rocco Papaleo, Trevico-Torino e Brutti, sporchi e cattivi si aprono con tono giustificatorio all’universo dei poveri ed emarginati, mentre C’eravamo tanto amati avvia un’indagine a ritroso nella dimensione “universale” della borghesia sullo sfondo degli avvenimenti che hanno segnato l’Italia. Le piccole storie singolari diventano racconti comuni, come in Una giornata particolare, La terrazza, La famiglia e La cena. La Storia diventa diuturno, muta nelle apparenze, ma non nella sostanza e lascia i suoi segni sugli eventi di ogni giorno. La malinconia dei crepuscolari Maccheroni, Splendor, Che ora è cede il posto al turbamento per la crisi politica e valoriale degli anni Novanta. Scola guarda indietro con nostalgia (Mario, Maria e Mario) e con sgomento all’oggi (Romanzo di un giovane povero): al pari di Un borghese piccolo piccolo, non c’è più spazio per la risata, I nuovi mostri prima derisi ora non consentono indulgenza alcuna. Dopo i documentari della Fondazione Cinema nel Presente, con Gente di Roma l’autore torna alle amate microstorie in un attento e appassionato ritratto del melting pot della capitale; e adesso, aspettando Che strano chiamarsi Federico, fuori concorso a Venezia 2013 e in sala dal 12 settembre, personale profilo – come già Sergio Amidei: ritratto di uno scrittore di cinema – dell’amico Fellini, non resta che sperare Scola torni presto a raccontare l’odierno, sgraziato certo, ma ricco di quei tratti umani che il regista ha sempre saputo (e aiutato a) osservare e capire.